
CARAVAGGIO, Crocifissione di San Pietro, 1600
La ricerca razionale della felicità
La coscienza razionale emerge dai meccanismi inibitori che hanno origine nel sistema dell’educazione, della formazione e dello sviluppo dell’individuo sociale. La madre, la famiglia, la scuola, la religione, la cultura e l’etica di riferimento svolgono un ruolo decisivo nel limitare e indirizzare l’azione dell’individuo verso la realizzazione di scopi adeguati al modello sociale e morale trasmesso dalla coscienza storica collettiva. I sistemi di inibizione coattivi sono indotti dalle leggi, dallle regole e dagli schemi selezionati dalla razionalità costruttiva, politica ed economica, che ha il preciso scopo di contenere la pulsione psichica (la protesta, la rivolta, il rifiuto) e indirizzare la libido verso gli aspetti materiali dell’esistenza (il lavoro, il benessere e il comfort). Questa forma di coscienza razionale, indotta e poi subita dall’individuo, ha il pregio di trasformare l’energia psichica in lavoro attraverso ‘forme meccanicistiche’ che esulano dalla ricerca della felicità, considerata dai filosofi greci l’unica finalità dell’anima. Ancora oggi la “cultura condivisa” che emerge dalle storie del cinema confonde la vera felicità con il successo nel lavoro e l’agiatezza economica che ne consegue, anche se nel film “La ricerca della felicità” (G. Muccino, 2006), il protagonista innalza il “sacrificio di sè” come “strumento tecnico” di “resurrezione” dell’anima dalla stato di miseria, di disagio e insoddisfazione materiale. All’anima non sono concessi prestiti, fidi o aiuti finanziari e nemmeno deroghe al pagamento delle imposte; non sono permesse agevolazioni, aiuti o sostegni da parte di terzi. L’alchimista, come il protagonista del film, deve cercare di evolvere rapidamente la percezione critica, sensoriale, razionale, intuitiva nella “percezione cognitiva”, decisiva a risolvere i giochi matematici (il cubo di Rubik), comprendere i giochi di coscienza (la psicologia di vendita) e infine tradurre la propria esperienza in un modello vincente utile per trarre profitto dalle circostanze, dalle opportunità, dal caso e dal destino (il protagonista si mette in proprio e diventa ricco). L’alchimia della percezione che evolve dalla cancellazione del punto di vista personale e dall’uso degli strumenti della ragione alchemica conduce il protagonista ad affinare l’osservazione, individuare i modelli di successo e ad imitare le tecniche che permettono la realizzazione del sogno di ricchezza. Tuttavia il sogno rischia di rimanere tale se l’anima non decide di tradurre la pulsione psichica in amore, fiducia e fede nelle proprie risorse psichiche, mentali e spirituali. Will Smith viene abbandonato dalla moglie, ma non per questo rinuncia a prendersi cura del figlio (metafora della responsabilità paterna che predispone alle virtù) e coltivare dentro di sè la speranza di cambiare vita, lavoro e status economico. Le diverse fasi descritte dal regista (fase della stupidità, della corsa, dello stage e della riuscita) rappresentano simbolicamente i quattro atti di trasformazione della coscienza razionale (il business “sicuro” degli scanner) nella coscienza alchemica in cui la Mente si mette in gioco per evolvere su un piano superiore di conoscenza, scaltrezza, abilità organizzative e capacità strategiche. L’Arte alchemica è come uno stage di sei mesi senza paga in cui l’alchimista impara a sue spese la tecnica di trasmutazione del mercurio (la percezione), di trasformazione dello solfo (la pulsione psichica) e di sedimentazione del sale (la conoscenza) indispensabili per affrontare la vita, le prove, gli ostacoli e le difficoltà su un nuovo livello di comprensione, di esperienza e di conoscenza di sè e del mondo. L’alchimia della trasformazione della pulsione è descritta metaforicamente dalle dodici prove affrontate da Ercole, ma la trasformazione della coscienza razionale, conforme alle paure psichiche proiettate dall’anima, permane occulta nei fatti del Vangelo. Non può esserci trasformazione dell’identità (il sole) e della coscienza di sè (la luna) se l’individuo non si mette in gioco e persiste a razionalizzare la propria vita in rapporto alle richieste della società o del proprio ego. La vicenda del duplice rinnegamento di Pietro descrive metaforicamente la paura dell’individuo di riconoscere dentro di sè la presenza della pulsione creativa in cui è racchiuso il potere “cristico” (l’istinto del cuore) di realizzare i desideri, le aspirazioni e il destino dell’anima. Cristo riconosce in Pietro il comportamento autoinibitorio dell’individuo che nega l’azione istintiva, la pulsione psichica e la libido sociale (la triplice negazione/i tre carnefici) al fine di costruire la coscienza morale in grado di fondare le istituzioni educative, la religione, gli ospedali e la Chiesa, ma non il “Tempio” della verità.
La ricerca razionale della felicità
La coscienza razionale emerge dai meccanismi inibitori che hanno origine nel sistema dell’educazione, della formazione e dello sviluppo dell’individuo sociale. La madre, la famiglia, la scuola, la religione, la cultura e l’etica di riferimento svolgono un ruolo decisivo nel limitare e indirizzare l’azione dell’individuo verso la realizzazione di scopi adeguati al modello sociale e morale trasmesso dalla coscienza storica collettiva. I sistemi di inibizione coattivi sono indotti dalle leggi, dallle regole e dagli schemi selezionati dalla razionalità costruttiva, politica ed economica, che ha il preciso scopo di contenere la pulsione psichica (la protesta, la rivolta, il rifiuto) e indirizzare la libido verso gli aspetti materiali dell’esistenza (il lavoro, il benessere e il comfort). Questa forma di coscienza razionale, indotta e poi subita dall’individuo, ha il pregio di trasformare l’energia psichica in lavoro attraverso ‘forme meccanicistiche’ che esulano dalla ricerca della felicità, considerata dai filosofi greci l’unica finalità dell’anima. Ancora oggi la “cultura condivisa” che emerge dalle storie del cinema confonde la vera felicità con il successo nel lavoro e l’agiatezza economica che ne consegue, anche se nel film “La ricerca della felicità” (G. Muccino, 2006), il protagonista innalza il “sacrificio di sè” come “strumento tecnico” di “resurrezione” dell’anima dalla stato di miseria, di disagio e insoddisfazione materiale. All’anima non sono concessi prestiti, fidi o aiuti finanziari e nemmeno deroghe al pagamento delle imposte; non sono permesse agevolazioni, aiuti o sostegni da parte di terzi. L’alchimista, come il protagonista del film, deve cercare di evolvere rapidamente la percezione critica, sensoriale, razionale, intuitiva nella “percezione cognitiva”, decisiva a risolvere i giochi matematici (il cubo di Rubik), comprendere i giochi di coscienza (la psicologia di vendita) e infine tradurre la propria esperienza in un modello vincente utile per trarre profitto dalle circostanze, dalle opportunità, dal caso e dal destino (il protagonista si mette in proprio e diventa ricco). L’alchimia della percezione che evolve dalla cancellazione del punto di vista personale e dall’uso degli strumenti della ragione alchemica conduce il protagonista ad affinare l’osservazione, individuare i modelli di successo e ad imitare le tecniche che permettono la realizzazione del sogno di ricchezza. Tuttavia il sogno rischia di rimanere tale se l’anima non decide di tradurre la pulsione psichica in amore, fiducia e fede nelle proprie risorse psichiche, mentali e spirituali. Will Smith viene abbandonato dalla moglie, ma non per questo rinuncia a prendersi cura del figlio (metafora della responsabilità paterna che predispone alle virtù) e coltivare dentro di sè la speranza di cambiare vita, lavoro e status economico. Le diverse fasi descritte dal regista (fase della stupidità, della corsa, dello stage e della riuscita) rappresentano simbolicamente i quattro atti di trasformazione della coscienza razionale (il business “sicuro” degli scanner) nella coscienza alchemica in cui la Mente si mette in gioco per evolvere su un piano superiore di conoscenza, scaltrezza, abilità organizzative e capacità strategiche. L’Arte alchemica è come uno stage di sei mesi senza paga in cui l’alchimista impara a sue spese la tecnica di trasmutazione del mercurio (la percezione), di trasformazione dello solfo (la pulsione psichica) e di sedimentazione del sale (la conoscenza) indispensabili per affrontare la vita, le prove, gli ostacoli e le difficoltà su un nuovo livello di comprensione, di esperienza e di conoscenza di sè e del mondo. L’alchimia della trasformazione della pulsione è descritta metaforicamente dalle dodici prove affrontate da Ercole, ma la trasformazione della coscienza razionale, conforme alle paure psichiche proiettate dall’anima, permane occulta nei fatti del Vangelo. Non può esserci trasformazione dell’identità (il sole) e della coscienza di sè (la luna) se l’individuo non si mette in gioco e persiste a razionalizzare la propria vita in rapporto alle richieste della società o del proprio ego. La vicenda del duplice rinnegamento di Pietro descrive metaforicamente la paura dell’individuo di riconoscere dentro di sè la presenza della pulsione creativa in cui è racchiuso il potere “cristico” (l’istinto del cuore) di realizzare i desideri, le aspirazioni e il destino dell’anima. Cristo riconosce in Pietro il comportamento autoinibitorio dell’individuo che nega l’azione istintiva, la pulsione psichica e la libido sociale (la triplice negazione/i tre carnefici) al fine di costruire la coscienza morale in grado di fondare le istituzioni educative, la religione, gli ospedali e la Chiesa, ma non il “Tempio” della verità.
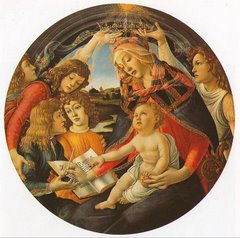
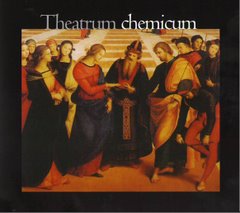
Nessun commento:
Posta un commento