 CARAVAGGIO. Incredulità di San Tommaso, 1600
CARAVAGGIO. Incredulità di San Tommaso, 1600Nell’educazione alla percezione si deve anche indicare che una ricerca superficiale dell’intelligibilità porta a ignorare il significato di un fatto o di un evento, così come una ricerca troppo ostinata dell’intelligibilità conduce a un errore razionalizzatore che altera questo significato. Si citeranno esempi di decisioni disastrose, prese non solo per imprevidenza, cinismo o mancanza di responsabilità, ma anche a seguito di processi psichici di assurda razionalizzazione o di occultamento inconscio, volti a preservare la nostra tranquillità personale.” Le parole di Edgar Morin, uno dei sociologi più attenti del nostro tempo, possono descrivere le motivazioni segrete che spingono Tommaso di infilare il dito nella ferita di Cristo. Che si tratti di semplice curiosità o di un eccesso di diffidenza o di intelligibilità in ciò che appare troppo o poco evidente agli occhi di tutti, resta il fatto che Tommaso è l’emblema del cercatore di verità, sempre in guardia a non cadere vittima delle facili illusioni, degli errori di valutazione o delle verità, troppo spesso esibite come dogmi o certezze assolute.
L’incredulità di San Tommaso non è una semplice descrizione di un evento raccontato dal Vangelo, ma si articola come un vero e proprio trattato in cui Caravaggio si preoccupa di far emergere la conoscenza di cosa significhi ricercare la verità con la ragione. Attraverso le linee guida della composizione geometrica, i volti dei quattro protagonisti sembrano suggerire un livello superiore di comprensione della realtà, indispensabile per toccare con mano, direttamente e senza mediazioni, la fonte della verità. Dalla ferita di Cristo sgorga “l’acqua e il vino”, metafora della trasformazione dei sentimenti cognitivi in valori morali, principi etici e consapevolezze spirituali. Ecco allora che il Cristo di Caravaggio presta il volto all’alchimista che porta a compimento l’opera di trasformazione della mente individuale nella ‘mente universale’ in grado di comunicare ‘amore e conoscenza’ attraverso un razionale dispiegamento di simboli, parabole, metafore e rituali iniziatici. Una conoscenza non è mai pura, non è mai una comprensione fedele e autentica di ciò che la curiosità del ricercatore, la sua intuizione e infine il suo intelletto sono state in grado di indagare e infine codificare in parole e immagini, tesi e antitesi, sintesi e allegorie, teorie e metafore, numeri e simboli. “Una conoscenza non è mai uno specchio delle cose o del mondo esterno. Tutte le percezioni sono nel contempo traduzioni e ricostruzioni cerebrali a partire da stimoli o segni captati e codificati attraverso i sensi” (Edgar Morin, 2001). Attraverso il senso più affidabile, quello della visione, arrivano al cervello gli innumerevoli errori della percezione che si accumulano e si sclerotizzano nel tempo a causa della pigrizia, dell’indolenza, dell’apatia e cioè dallo stato della mente. Ciò che determina l’acutezza della percezione è lo stato mentale soggettivo che è subordinato dalla presenza dei “tre draghi” che disturbano la percezione di sé stessi e deformano la comprensione della realtà. Il primo drago è il simbolo del potere velante che impedisce la trasmutazione della pigrizia, dell’apatia e dell’indolenza in curiosità, desiderio di conoscere la verità, di studiare e di esplorare il mondo con le facoltà dell’immaginazione creativa. Il secondo drago è un potere proiettivo che racchiude dentro di sé gli aspetti consci, subconsci e inconsci della personalità in grado di inibire il naturale flusso dell’energia psichica e mentale nel sistema della percezione sensoriale e intuitiva. Il terzo drago, infine, è il più difficile da elaborare poichè evolve con la personalità conscia ed esprime le qualità del ritmo armonico. L’identificazione con credi, pensieri, emozioni, paure, meccanismi di difesa, conflitti, complessi e fattori istintivi come avidità, orgoglio e avversione, creano una distorsione profonda nel processo di decodificazione di ciò che viene percepito e memorizzato. E’ questo il drago che Caravaggio decide di autodecapitare, come primo atto di purificazione del pensiero razionalizzatore (Golia) in cui cova, come la cenere, la volontà di dominare le cose, le idee e i sistemi di interpretazione della verità. All’errore della percezione si aggiunge l’errore intellettuale. Il sapere del Rinascimento è generato dalla sensibilità psichica dell’artista e del filosofo che sperimentano direttamente il dualismo esistente tra il sistema cognitivo intuitivo di “Davide” e il sistema cognitivo razionalizzatore di “Golia”.
La conoscenza occidentale si dispiega sotto forma di parole, di idee, di teorie ‘partorite’ dalla mente razionale. Ogni sapere è il frutto di una traduzione/ricostruzione di una conoscenza che la precede. Tale traduzione è attuata attraverso i mezzi del linguaggio e del pensiero, e perciò sperimenta il rischio dell’errore. Questa conoscenza, a livello sia di traduzione delle parole che di decodificazione delle immagini, introduce il rischio dell’errore dell’interpretazione all’interno della soggettività che conosce, della sua visione del mondo e dei suoi principi di conoscenza.
Caravaggio rinuncia ad esprimere un’opinione intellettuale, di manifestare un punto di vista personale o di interagire con le decisioni dei committenti nella scelta dei soggetti. Scopre così la “legge della sincronicità”, che gli offre, con tempismo stupefacente, l’opportunità di sperimentare il potere dell’intuizione creativa di sondare le verità nascoste nei soggetti di ispirazione religiosa o mitologica.
La rinuncia a controllare il mondo attraverso i sistemi di idee, dottrine e ideologie equivale a un atto iniziatico ritenuto fondamentale nella filosofia rinascimentale.
Ciò significa ‘decapitare’ la superbia connaturata al pensiero forte di Golia, per cui Caravaggio incide sulla spada di Davide le lettere Has o s, sintesi del motto “Humilitas occidit superbiam”.
Contenere “la vanità intellettuale del pavone” all’interno del vas hermeticum della mente è un atto iniziatico che facilita l’evoluzione della percezione critica e cognitiva in intuizione consapevole dei sentimenti e delle emozioni, delle motivazioni e delle intenzioni, dei simboli e degli archetipi. Caravaggio va oltre i limiti della razionalità organizzatrice e virtualmente compie un atto di “morte e trasformazione” dell’intelletto critico e speculativo nella mente creativa di Davide, la cui fionda è il simbolo della sincronicità operativa dei due emisferi cerebrali.
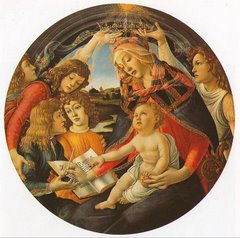
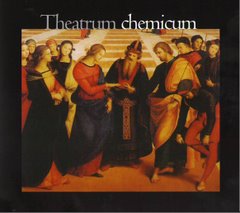
Nessun commento:
Posta un commento