 CARAVAGGIO, Riposo durante la fuga in Egitto, 1595
CARAVAGGIO, Riposo durante la fuga in Egitto, 1595La percezione sensoriale può essere guidata, influenzata e modificata, e in vari modi, dal subconscio, dall’attenzione, dallo stimolo esterno, dalla pulsione sessuale, dal sistema delle convinzioni, dalla libido di possedere l’oggetto del desiderio, oppure dall’intenzione consapevole di voler vedere, comprendere e assimilare gli elementi di bellezza (frequenze infrarosse), di verità (vibrazioni ultraviolette) e di perfezione (equilibrio di rosso e blu) che sono racchiusi nelle immagini, e solo nelle immagini, così come si presentano agli occhi della coscienza. Già nelle prime opere Caravaggio sviluppa i temi della conoscenza critica della realtà (vedi Q1) che conducono in breve tempo la curiosità creativa dell’artista a indagare tutti gli aspetti e i contenuti di ‘bellezza, verità e perfezione ‘presenti nelle parole del Vangelo. Le vicende e i soggetti delle sacre scritture, investiti dall’intenzione dell’anima intellettiva di comprendere, interpretare e rendere attuale la “coscienza sacra”, inspirano all’artista i principi di una nuova “musica”. Nel dipinto “Riposo durante la fuga in Egitto” Caravaggio giunge a definire il silenzioso rapporto che lega le intuizioni sensoriali (la madre) con le emozioni del cuore (il figlio). Maria e il figlio Gesù, teneramente abbracciati in un momento di riposo, descrivono il legame indissolubile di pensieri ed emozioni, di intuizioni e senzazioni, di ricordi e sentimenti che si forma all’interno dell’individuo che si sofferma, anche solo per un attimo, a riflettere sui contenuti dell’esperienza. Dall’altra parte della coppia, San Giuseppe incarna la coscienza sensoriale dell’alchimista che rinuncia ad interferire (il padre putativo) con pensieri critici, idee pre-confezionate e intuizioni astratte nel processo di elaborazione delle informazioni sensoriali proveniente dal sistema automatico della percezione (la Vergine Madre) collegato alla memoria emotiva (Gesù bambino). La presenza dell’asino sulla scena rende esplicita l’intenzione di Caravaggio di ricondurre la “ricerca della verità” su un livello pre-razionale in grado di esonerare l’intelletto dall’impegno, dall’ansia e dalla sofferenza di non riuscire a comprendere la logica della vita, i molti perchè dell’esistenza o le ragioni della follia scatenata dai “proseliti di Erode” che da secoli proseguono imperterriti a fare strage di innocenti.
Il riposo della Sacra famiglia durante fuga in Egitto viene reinterpretata da Caravaggio in chiave metaforica al fine di stabilire un punto fermo della ricerca spirituale. L’assenza di egoicità conduce l’io putativo (San Giuseppe) ad esercitare un ruolo unicamente rappresentativo. Non è il padre biologico del “bambino” poichè le “emozioni del cuore” sorgono spontanee indipendentemente dalla volontà dell’individuo, così come non si intromette mai, in nessun passo del Vangelo, nel rapporto che unisce l’esperienza delle emozioni (il figlio) con l’elaborazione percettuale delle intuizioni (la madre). Ciò significa che l’io alchemico deve rinunciare alle facoltà peculiari del linguaggio e del pensiero logico-razionale di descrivere la realtà, poichè il corpo è in grado di elaborare autonomamente un sapere sufficientemente logico e intuitivo poichè capace di cogliere la verità direttamente dalle immagini riflesse, e di fare leva sulle facoltà della percezione sensoriale di comprendere il tutto a partire dall’indizio allusivo della parte. Per gli studiosi moderni, come Gehlen, tale capacità, già in azione a livello percettivo-motorio, percorre tutti i processi cognitivi fino alle forme più evolute del linguaggio logico e translogico. L’apertura al mondo dei sensi, regno incontrastato della consapevolezza emotiva che evolve dalla cura del corpo, dalla sensibilità epidermica e dalla propriocezione, è all’origine della conoscenza sensoriale, rappresentata nella relazione che il corpo divinizzato instaura con Dio (la Verità). A partire dunque dalla conoscenza delle sensazioni, e dalla loro nominazione (il giorno della creazione del mondo naturale), l’alchimista sviluppa la capacità analogica di estendere la comprensione della realtà attraverso la percezione cognitiva dei sentimenti corporei (il Logos) e attivare quindi le facoltà dell’autoespressione (il Verbo) con cui è possibile accedere a stadi superiori di conoscenza simbolica. “Il mondo dei sensi è dunque simbolico, e questo significa che allusioni, abbreviazioni, parti anteriori e intersezioni, ombre, riflessi, qualità cromatiche o formali vistose bastano a dar conto delle masse reali degli oggetti. L’opportunità biologica di questo fatto risiede da un lato nell’esonero e nell’accelerazione delle reazioni in tal modo possibili, dall’altro, e soprattutto, nell’essere la visione panoramica possibile soltanto in aree simboliche”. Questa forma di esonero e accelerarazione delle reazioni, resa possibile dalla decisione di astenersi da ogni forma di analisi, calcolo o giudizio schematico (il cosidetto “paraocchi”), consente alla ‘mens cogitativa’ di cogliere e memorizzare intere aree di allusioni. “Soltanto allora è possibile abbracciare con uno sguardo complessivo superfici alquanto estese, e la percezione, che così può ignorare singole masse, si rende disponibile per prestazioni superiori, appunto panoramiche” (Gehlen, 1956). L’alchimista che “fugge” nella terra d’Egitto, chiamata anticamente Al - Khemia (terra nera), si appresta così a iniziare lo studio dei “segni, dei simboli, delle allegorie e dei geroglifici” indispensabili per ricostruire il Sapere che ha origine nell’argilla, la prima materia con cui Dio modella l’Adamo terrestre.
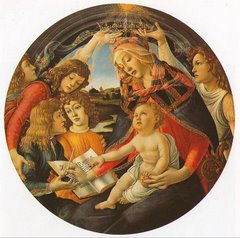
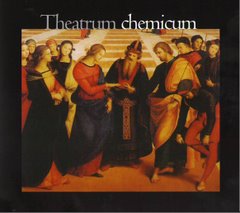
Nessun commento:
Posta un commento